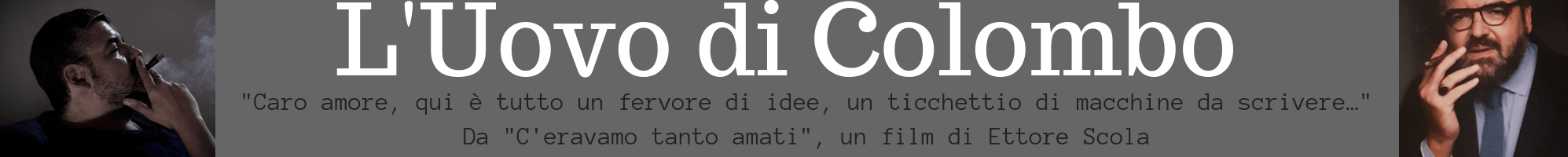Tre scenari futuribili per la battaglia del Senato. Quando la storia si fa con i “se”
15 Settembre 2015“Se Napoleone avesse vinto a Waterloo” è il primo degli esempi storici di quella che viene chiamata “storia controfattuale”: la storia fatta con i “se”. In campo storico, è un divertissement, in politica, invece, è un classico. La politica, infatti, è piena di “se”: se succede questo, non succede quest’altro e viceversa. Insomma, la politica dei “se” è il paradiso di ogni retroscenista politico…
Abbiamo applicato il metodo della storia controfattuale alla battaglia in corso sulla riforma del Senato. Tante le variabili, forse troppe, sia tattiche che strategiche, della battaglia in corso. Chiari e definiti sono soltanto i cinque eserciti in campo: il premier Renzi, il ministro Boschi e il suo governo, più la sua maggioranza; la minoranza dei ribelli dem e gli altri senatori inquieti della maggioranza (Ncd in testa); le forze dell’opposizione; il presidente del Senato Grasso. Attore non protagonista, ma comunque sul campo come osservatore, il Capo dello Stato Mattarella.
Sommario
Primo scenario. Renzi recupera i voti dei senatori e passa l’esame. Il governo arriva al 2018

L’attuale composizione del Senato (agosto 2015)
La minoranza del Pd, una volta il tavolo delle trattative interne con la maggioranza renziana, non si accontenta e punta all’obiettivo grosso: cercare di cambiare l’articolo 2 del ddl Boschi, trasformando il Senato da non elettivo (o, meglio, elettivo di secondo grado, così come previsto nella riforma) a elettivo, cioè eletto direttamente dai cittadini. L’operazione di forza, però, per un pelo, non riesce. Infatti, con un piccolo aggiustamento (l’art. 35 del ddl Boschi che cambia l’art. 122 Costituzione), Renzi spacca il fronte dei ribelli: al Senato vengono restituite una serie di funzioni perdute nel primo passaggio (I e II lettura) tra Senato e Camera e la mediazione offerta dal governo (un ‘listino’ di consiglieri senatori da eleggere sempre nell’ambito dei consigli regionali, ma salvaguardando la scelta dei cittadini che, sulla scheda, indicano quali consiglieri regionali inviare nel futuro Senato) viene accettata da una parte di loro. Roberto Calderoli ritira gran parte dei suoi emendamenti (513 mila) per cercare comunque l’imboscata, ma la presidente della I commissione, Anna Finocchiaro, manda il testo direttamente in Aula per rispettare la tabella di marcia (voto finale per il 15 ottobre).
Ed è qui, in Aula, che il governo trova un aiuto inaspettato

Pietro Grasso
Il presidente del Senato, Pietro Grasso, riapre alle modifiche sull’articolo 2, quello sull’elettività del Senato, solo nella preposizione contestata, il comma V, quello che contiene una piccola modifica apportata dalla Camera, dove un ‘nei’ consigli regionali è diventato ‘dai’. Ma la novità è che Grasso chiude alla possibilità di emendare all’intero articolo 2. Il governo, a questo punto, sfida l’Aula, legando di fatto, anche se non con un voto di fiducia formale (impossibile) la sua sopravvivenza al voto favorevole all’art. 2. Nel caos generale, tra le proteste delle opposizioni che inveiscono contro Grasso, e sotto il ricatto della possibile fine della legislatura paventato dal premier in molti retroscena, i ribelli si dividono: sui 25-28 che erano sulla carta, ben dieci decidono di accettare la parziale mediazione del governo. Ne restano 15 ad andare avanti nella battaglia, ma nel frattempo sono successe altri tre fatti: il gruppo Ala, guidato da Denis Verdini, è cresciuto di ben cinque unità, tutti presi dal gruppo di FI, la fronda dei senatori ribelli di Ncd si è ridotta a tre irriducibili in cambio di posti di sottogoverno e cinque senatori azzurri non si fanno trovare in Aula, adducendo scuse varie, al momento del voto. La maggioranza ce la fa, sia sull’articolo 2 e con 161 voti (la maggioranza assoluta non serve, ma c’è) contro 145, che sul resto della riforma, che ovviamente viene votata molto più tranquillamente.
Il governo, forte del successo, si dedica a preparare la legge di Stabilità per il 2016 e il premier promette che governerà “di sicuro fino al 2018”. La minoranza dem mastica amaro, chiede nuovi cambiamenti e promette battaglia su altri fronti, ma il Pd riunisce i suoi gruppi dirigenti e decide che “non vi potranno più essere voti difformi nei gruppi, tranne sui temi etici, pena l’espulsione”. Un gruppetto di senatori (Gotor, Mucchetti, Mineo, etc.) e di deputati (D’Attorre, etc.) se ne va e, insieme a Fassina e Cofferati, presentano una nuova formazione politica: il Partito della Sinistra. Bersani e D’Alema restano ancora nel Pd, ma dichiarano che non sanno “fin quando sarà possibile”. Dall’altra parte, il sostegno di FI alla riforma contribuisce a spaccare il fronte del centrodestra tra Renzi e Berlusconi, che annuncia il ritiro dalla scena politica, e Grillo vede una rottura nell’M5S. Nel giugno del 2016 si celebrano le elezioni amministrative in molte grandi città (Torino, Milano, Napoli, Bologna, Genova): il Pd approfitta della ripresa economica e vince tutte le sfide, tranne Napoli. A ottobre del 2016, si celebra il referendum istituzionale: è un plebiscito per Renzi.
Renzi rinsalda l’alleanza di governo con nuovi acquisti in Parlamento. Si vota solo nel 2018 e lo slogan della campagna elettorale, di piglio obamiano, è “Quattro anni ancora! Forza Matteo!”.
Secondo scenario. Renzi non ce la fa, il Senato boccia la riforma. Si va al voto e verso il caos
Renzi e la Boschi s’intestardiscono a non volere nessuna mediazione, con la minoranza dem, ma i tentativi di spaccarla si rivelano inutili. Lotti assicura il premier di avere comunque i numeri, ma già quando il testo del ddl Boschi va in Aula si vedono le prime crepe: sull’art. 1 (funzioni del Senato) il governo rimane sopra le opposizioni per un pugno di voti. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, decide di aprire all’emendabilità di tutto l’articolo 2, non solo per il V comma, ma per tutti. Il clima è tesissimo: Renzi è furibondo, tutto il governo è schierato in Aula, gli appelli alla minoranza perché ragioni si sprecano, ma i ribelli non demordono e anche i tentativi di spaccarli non riescono più. Solo cinque senatori rompono il fronte, uscendo dall’Aula (al Senato l’astensione è voto contrario), ma Verdini, che aveva assicurato a Lotti nuovi ingressi per compensare le perdite dei ribelli dem, non riesce nell’intento. I senatori di Ncd, fiutata l’aria, e cioè che Renzi può promettere poco o nulla, vanno ad accrescere le fila dei ribelli e persino nel placido gruppo delle Autonomie e tra i senatori a vita, gelosi di perdere identità e futuro, si registrano defezioni. Quando si arriva al voto sull’art. 2, succede il finimondo: le opposizioni gridano al golpe e alla democrazia violata, girano voci di un Capo dello Stato irritatissimo per la forzatura che il premier ha cercato e si aprono scenari inediti: c’è chi dice che Mattarella sarebbe pronto a dare un incarico istituzionale a un alta personalità, e si fa il nome dello stesso Grasso, per un governo che trovi una maggioranza alternativa in Parlamento.

Matteo Renzi
Dopo una giornata di liti e di insulti, con l’Aula del Senato ridotta a una bolgia, il governo va sotto: FI vota compatta contro il governo, come tutte le opposizioni, e insieme ai ribelli (25) e Ncd (10): finisce 160 a 137 per le opposizioni, tra urla di giubilo e sfottò di queste, renziani lividi e furibondi. Renzi ammette di non avere più la maggioranza al Senato, sale al Colle, ma si dichiara indisponibile a formare qualsiasi altra maggioranza alternativa, parlando a nome del partito di maggioranza relativa in Parlamento, il suo, il Pd. Mattarella prova comunque a formare un altro governo, che traghetti il Paese oltre la Legge di stabilità e verso il voto, ma le opposizioni sono divise tra loro e il tentativo esplorativo, affidato a Grasso, fallisce nel giro di pochi giorni. A quel punto, al Capo dello Stato non resta che riaffidare l’incarico a Renzi: si tratta però di un governo di minoranza che deve solo evitare che i mercati, già in subbuglio, le istituzioni europee e le cancellerie dei maggiori paesi, molto preoccupati per la nuova esplosione dell’instabilità politica in Italia, creino intorno al Paese un cordone sanitario come con la Grecia e costringano l’Italia a misure severe sul fronte economico. Il II governo Renzi, un monocolore Pd, fatto solo di fedelissimi, approva una Legge di Stabilità limitata negli scopi e negli obiettivi: l’Imu non viene abolita, la Ue non lo permette, le tasse salgono e il problema immigrati alle frontiere aumenta fino ad esplodere. Nel frattempo, Renzi ha preso provvedimenti durissimi contro i ribelli al Senato, tutti cacciati dal Pd, e attacca con violenza Bersani e D’Alema, accusandoli apertamente di aver fomentato il loro voto contrario. La minoranza si riunisce al teatro Eliseo con pulmann che arrivano da tutta Italia, tornano a sventolare le bandiere del Pds e persino del Pci. Civati, Cofferati e Vendola, tutti i fuoriusciti, partecipano all’assemblea e promettono che nascerà un nuovo Partito della Sinistra (PdS) unito, progressista e laburista, collegato a Cobyrn in Gran Bretagna, Podemos in Spagna e Syrizia in Grecia.
E’ la scissione.
A febbraio 2016 Renzi si dimette e Mattarella scioglie le Camere. Si vota prima delle comunali. La campagna elettorale è infuocata, il problema immigrazione esplode, Berlusconi cede lo scettro del centrodestra alla Lega di Salvini, ma il M5S di Grillo candida Di Maio premier, che si accredita in tutte le capitali europee e rassicura i mercati e le ambasciate straniere. Con l’Italicum (entrato in vigore in via anticipata) alla Camera e il Consultellum al Senato, il Paese va a votare stremato. Il Pd ottiene un risultato modesto, molto inferiore alle aspettative, il 31%, l’M5S è davanti con il 33%, il centrodestra, nonostante la campagna durissima di Salvini, non supera il 25% causa crollo di FI. Soprattutto, il Fronte della sinistra conquista un inaspettato 9% dei voti. Nessuno potrebbe governare a causa dei diversi sistemi elettorali, ma molti senatori del Pds sono concentrati al Senato dove hanno vinto nelle regioni rosse. Dopo una mini-scissione e mille tormenti, il Pds decide di appoggiare, senza ministri ma con un presidente della Camera e molte assicurazioni sul programma, un governo Di Maio, e cioè un monocolore dell’M5S. Inizia una fase politica difficile e incognita.
Terzo scenario. Renzi passa, ma con il governissimo. Nel Pd nasce un’alternativa di sinistra

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana (Foto tratta da quirinale.it)
La minoranza dem rifiuta ogni accordo, ma si mantiene compatta. Capisce subito, però, che qualcosa non va nel resto delle opposizioni. Calderoli decide, in cambio di ‘rassicurazioni’ sulle maggiori autonomie regionali e sui nuovi poteri del Senato, ritira la sua mole di emendamenti. Forza Italia inizia a dialogare con la maggioranza e il governo sui poteri e le funzioni del Senato. Nonostante i ribelli dem restino arroccati sulle loro posizioni in un numero considerevole (25-28), Forza Italia si dichiara disposta a esaminare ‘senza pregiudiziali’ i ‘passi in avanti’ fatti sulla riforma e il presidente del Senato Grasso limita l’emendabilità dell’articolo 2 al solo contestato comma V. Molti senatori, del gruppo Misto (gli ex grillini), di Ncd e di Autonomie, temono per il loro futuro: Renzi fa sapere loro, tramite Lotti, che se non passa la riforma, si va al voto e addio legislatura. La minoranza dem pensa di essere compatta, ma tra la notte e la mattina prima del voto perde 10 unità. Il voto sull’articolo due diventa una passeggiata: sono 175 i voti a favore del governo, appena 130 quelli per le opposizioni perché Forza Italia esce in blocco dall’aula e, nonostante la fronda di una decina di senatori di Ncd, la ribellione della minoranza dem è stata piegata. Ma Renzi paga dazio.
La polemica della minoranza contro il ‘nuovo’ patto del Nazareno si fa fortissima.
Anche la legge di Stabilità viene approvata con il voto favorevole degli azzurri. Berlusconi, però, decide di cedere definitivamente lo scettro della leadership del centrodestra a Salvini in cambio di un patto ‘tra gentiluomini’: non puoi fare tu il leader, sei troppo radicale, Merkel e gli altri non ti accetterebbero, invece Maroni è perfetto, ragionevole e gradito ai moderati, vedrai che con lui vinciamo le elezioni. La profezia berlusconiana, stavolta, si avvera. Il Pd non subisce alcuna scissione, tranne pochissimi senatori dissidenti, ma Bersani e D’Alema iniziano a riorganizzare la scalata al partito e a boicottare Renzi in vista delle urne. Il premier, indebolito dall’abbraccio sempre più ambiguo di Forza Italia e sottoposto al fuoco di fila delle polemiche sull’immigrazione e sulle tasse, ma anche dalla scissione silenziosa della sua minoranza che continua a punzecchiare il governo e a farlo ballare alle Camere, supera a fatica l’estate dopo aver preso una brutta legnata alle amministrative della primavera 2016. Il Pd perde a Napoli e, soprattutto, a Milano, dove rivince il centrodestra con Paolo Del Debbio, eletto a furor di popolo, e vince male e stentato a Torino e Bologna, perdendo persino Genova. Dopo un’estate di polemiche e crisi nella maggioranza, con Ncd che rientra, pezzo dopo pezzo, in FI e la Lega che, dopo la sterzata moderata, ha messo Maroni come candidato premier del centrodestra il premier si gioca la carta del tutto per tutto: apre la crisi di governo e si dimette per abbinare le elezioni politiche al referendum istituzionale sul Senato. Ma la polemica di Grillo e Lega sul Senato inutile e, comunque, non abolito, il logoramento della sinistra interna al governo e dentro il Pd, un Berlusconi rinato nella forma di regista del centrodestra, logorano il Pd fino al tonfo inaspettato. Centrodestra avanti, primo schieramento, al 35% centrosinistra secondo, a un incollatura, 34%, ma senza Sel, M5S al 31%. Impossibile formare un governo di un solo polo, grandi intese obbligate. Berlusconi, dopo l’ennesima rottura con la Lega, che non ci sta al ‘governissimo’ e viene scaricata, condiziona fortemente la nascita di un nuovo governo Renzi, cui pure concede il nuovo incarico. Renzi accetta, ma deve subire la presenza di molti ministri dichiaratamente di centrodestra e un programma semiconservatore, liberista sulle tasse, ma chiuso sui fronti immigrazione e diritti civili.
La polemica, dentro il Pd, che ha rieletto molti deputati e, soprattutto, senatori della sinistra interna, divampa sempre più forte.
La minoranza chiede, e ottiene, un congresso anticipato, anche se di pochi mesi, a inizio (e non alla fine) del 2017 per poter approfittare dei colpi d’immagine che Renzi subisce uno dietro l’altro. Bersani e D’Alema fanno un passo indietro, Speranza e Cuperlo pure. Dopo anni di incubazione e di studio, un giovane deputato del modenese, Enzo Lattuca, ‘caruccio’ quanto basta, ma profondamente di sinistra, viene lanciato come il nuovo outsider di Renzi. La campagna per le primarie, dentro il Pd, diventa infuocata: un pezzo della ex sinistra che si era schierata con Renzi torna sui suoi passi e, nelle regioni rosse, la minoranza diventa maggioranza. La disaffezione di un gran pezzo dei nuovi elettori filo-renziani che sono defluiti dal Pd all’astensione fa il resto: Renzi perde le primarie e, nel 2017, si dimette anche da premier, dicendo ‘preferisco fare altro, anche Obama e Blair lo hanno fatto. Lancerò una Fondazione, ripartirò da zero”. Il Pd, in mano al giovane Lattuca, torna di sinistra e chiede di tornare alle urne per il 2018.
NB. Questo articolo è stato scritto in forma originale per il sito di Quotidiano.net