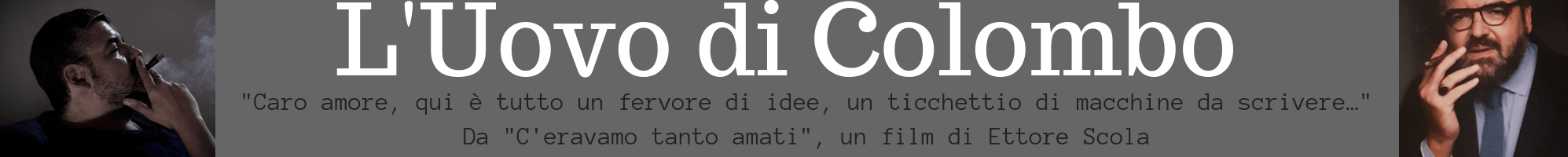La “disconferma”. Un’analisi puntuale e testuale del linguaggio dei politici frutto del lavoro del professor Mercadante
22 Aprile 2018L’autore dell’articolo che state per leggere è il professore Francesco Mercadante, ex professore all’Università di Palermo (Istituto di Lettere e Filosofia) e ideatore di un sistema di analisi del linguaggio detto “linguistica previsionale“.
Ospito con piacere sul mio blog un suo articolo sul linguaggio della Politica e dei politici.

I principali leader dei partiti presenti alle elezioni politiche 2018
“Tu credi, immagino, che il nostro compito principale consista nell’inventare parole. Neanche per idea! Noi le parole le distruggiamo, a dozzine, a centinaia. Giorno per giorno, stiamo riducendo il linguaggio all’osso (…) È qualcosa di bello, la distruzione delle parole. Naturalmente, c’è una strage di verbi e aggettivi, ma non mancano centinaia di nomi di cui si può fare tranquillamente a meno. E non mi riferisco solo ai sinonimi, sto parlando anche dei contrari. Che bisogno c’è di una parola che è solo l’opposto di un’altra? Ogni parola già contiene in sé stessa il suo opposto. Prendiamo ‘buono’, per esempio. Se hai a disposizione una parola come ‘buono’, che bisogno c’è di avere anche ‘cattivo’? ‘Sbuono’ andrà altrettanto bene, anzi meglio perché, a differenza dell’altra, costituisce l’opposto esatto di ‘buono’. Ancora, se desideri un’accezione più forte di ‘buono’, che senso hanno tutte quelle varianti vaghe e inutili: ‘eccellente’, ‘splendido’ e via dicendo? ‘Plusbuono’ perfettamente il senso, e così ‘arciplusbuono’, se ti serve qualcosa di più intenso”. (George Orwell, 1949, Nineteen Eighty-Four, trad. it. di S. Manferlotti, 1950, 1984, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, p. 55).
Ogni parlante sviluppa la propria capacità di appartenenza e adattamento al mondo e, principalmente, alla comunità linguistica attraverso gli atti rappresentativi (Cfr. J. L. AUSTIN, 1962, How do Do Things with Words, trad. It. di C. Villata, 1987,Come fare cose con le parole, Casa Editrice Marietti, Genova.) ossia per il tramite di atti linguistici come, per esempio, il descrivere o l’affermare che ci permettono di aderire alla convenzione, di stare gli uni vicini agli altri. I politici, tuttavia, non possono mai concedersi questa prossimità affettiva ed emotiva. Nei loro discorsi non si fa fatica a riconoscere il segno della perenne reversibilità; sembra che per loro il tempo convenzionale non scorra, fissato in una sorta di atemporalità mitologica in cui si celebrano i misteri di un regno invisibile. La loro giornata è spesso inquadrata da significati ‘altrui’ e scandita dall’ingestione di un necessario cocktail di sostantivi ‘inesistenti’. Tra un significato e l’altro, sono soliti intrattenere i propri interlocutori con storie senza trama né climax di una dimensione che non si esplica in alcuna realtà: ininterrottamente e appassionatamente, mettono in fila significati e significanti, senza che gli uni si leghino agli altri. Molti discorsi politici s’impongono come spazi vuoti della comunicazione, paradossalmente, acquisiscono forza proprio perché non possiedono alcun significato specifico; si possono riempire a piacimento, saturare, ma non troppo, perché fungono da ammortizzatori linguistici, luoghi entro i quali tutti possono dire un po’ di tutto, garanzie di compartecipazione.
Ma i pensieri sono un caso estremamente interessante, cioè sconcertante: si ha qui l’insincerità che è un elemento essenziale nel mentire, in quanto questo è distinto dal semplice dire ciò che di fatto è falso. Ne sono esempi il pensare, quando dico “innocente”, che il fatto sia stato compiuto da lui, o pensare, quando dico “mi congratulo”, che l’azione non sia stata eseguita da lui. Ma io posso di fatto sbagliarmi nel pensare così.
È vero, bisogna ammetterlo: spesso, il valore dell’eloquio si misura per l’efficacia dell’effetto di straniamento sull’ascoltatore. La capacità dell’oratore consisterebbe dunque nello stabilire legami d’assenza tra il vero fine e quello rappresentato dai significanti. In altre parole, ciò che non viene detto, ma solo percepito, diventa oggetto di curiosità e desiderio. Il compito non è affatto facile, come in genere si pensa, perché, da un lato, è necessaria una grande capacità di autocontrollo, mentre, dall’altro, occorre scegliere con cura parole, locuzioni e sintagmi che rimandino a qualcosa d’assente e importante.
Con umiltà e diligenza, allo scopo di verificare la validità delle nostre ipotesi ludiche, abbiamo sottoposto ad analisi le dichiarazioni fatte al Quirinale da Di Maio, Salvini e Martina, i principali protagonisti della consultazione elettorale. L’imparzialità è stata nostra alleata. Bisogna dire, nello stesso tempo, che i summenzionati oratori non si sono affannati parecchio per distinguersi l’uno dall’altro, sembrando, in alcune circostanze, allievi d’una stessa scuola di formazione politica.
Di Maio, leader del primo partito del paese, senza tergiversare, introduce immediatamente il sostantivo responsabilità, dicendo: “Abbiamo detto prima di tutto al Presidente della Repubblica che sentiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica del paese e di lavorare prima possibile per assicurare una maggioranza ad una governo del cambiamento che guardi al futuro, che porti avanti le lancette dell’orologio, gli abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro (…)”.
Tralasciamo la grammatica per concentrarci su pragmatica e semantica; in parole povere, ci dedichiamo a usi e significati. Prima di ogni cosa, isoliamo alcune aree ‘tematiche’ che dovrebbero essere fondamentali e dalle quali dovremmo comprendere l’originalità linguistica di Di Maio, le sue peculiarità, i suoi tratti distintivi: responsabilità, come s’è già detto, lavorare, governo del cambiamento, governo che porti avanti le lancette dell’orologio e, ancora, lavoro. Il sostantivo astratto responsabilità particolarmente interessante perché costituisce il comune denominatore di tutte e tre le dichiarazioni, quella di Di Maio, quella di Salvini e quella di Martina. L’uso di responsabilità determina di colpo, specie in questo contesto, un tono grave, un’attitudine di solennità, ma, se ne vogliamo rispettare l’etimo, dovremmo attenderci poco dopo una risposta a qualcosa. Responsabilità solo in apparenza un termine astrato, dal momento che trae origine dal latinorespondere. Sappiamo per certo tuttavia che la risposta a qualcosa, per esempio un impegno che dovrebbe essere messo in parola, non c’è.
Salvini non è da meno nell’usarlo e fa un piccolo passo avanti e almeno tre indietro. L’occasione è sempre la stessa, le dichiarazioni al Quirinale in seguito alle consultazioni presso il Capo dello Stato: “(…) Cercando di esercitare quella responsabilità che i Presidenti di Camera e Senato hanno visto come protagonista (…)”.
L’uso che ne fa Matteo Salvini genera un modesto passo avanti, quantunque sia indiretto e improprio. Si tratta di una modalità indiretta perché è rinviata a delle figure istituzionali che non hanno ancora svolto alcun ruolo; di conseguenza, ci chiediamo come avrebbero potuto rispondere a qualcosa di concreto. È improprio, nello stesso tempo, se teniamo in debita considerazione che l’elezione dei Presidenti dei due rami del Parlamento è espressione di una volontà politica, non dell’esercizio d’una qualche responsabilità sociale e civile, che del resto spetta, com’è noto, all’intero Parlamento in attività. Forse, a questo punto dell’analisi, i passi indietro fatti da Salvini sono più di tre.
Che cosa fa Martina a tal proposito? Fa il proprio dovere. Parla di responsabilità e, rivolgendosi, ai vincitori: “(…) Si facciano carico fino in fondo di questa responsabilità (…) Buona parte degli atteggiamenti che queste forze hanno sono più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che non invece di una responsabilità nuova (…)”.
Nella primo tentativo, il segretario del PD è quasi corretto e lineare, anche se avrebbe dovuto esplicitare il senso di questa responsabilità: un grave errore, questo, considerando che un oppositore politico dovrebbe incalzare i propri interlocutori su uomini e fatti, chiamando le cose col loro nome, senza lasciare il campo aperto e indifeso. Di fatto, il PD commetteva questo errore anche quando era al governo, quindi mostra una certa coerenza. Se nella prima parte, di fatto, possiamo rilevare l’attenuante dell’afflizione e dell’esigenza di riscatto, nella seconda parte non giustifichiamo il disastro, fuorché con l’abitudine al politichese contemporaneo. Associare responsabilità con l’aggettivo nuovo, cioè con un aggettivo qualificativo che, in sostanza, non è sufficiente a qualificare alcunché, si traduce nell’ennesimo autodenuncia linguistica, come in una sorta di espiazione nel dolore. Non solo si ha il vuoto del sostantivo, ma si aggrava anche la situazione col vuoto dell’aggettivo. Che vuol dire responsabilità nuova? Si tratta di un binomio linguistico che ciascuno di noi potrebbe utilizzare, a prescindere dallo schieramento politico. Chi mai potrebbe rifiutarsi di assumersi una responsabilità nuova?
Insomma, qual è la tecnica di questi oratori? Non possiamo parlare di vera e propria tecnica, a dire il vero; non possiamo farlo soprattutto perché questo ‘modo linguistico’ non è vantaggioso per chi lo usa: è povero di metafore, quasi del tutto privo di aggettivi, sono scomparsi gli aneddoti, che un tempo arricchivano la politica, i verbi sono sempre ‘meno narrativi e descrittivi’ e così via. Di conseguenza, è difficile immaginare che un qualsivoglia oratore proceda dritto verso la propria disfatta. Non pretendiamo mica che prendano le sembianze del Marcantonio del Giulio Cesare di Shakespeare, ma un po’ di fatica in più ci vorrebbe. Una notazione è doverosa: tutti, ma proprio tutti, fanno ampio e inspiegabile uso di iperonimi. Sul Treccani online leggiamo: <fiore è iperonimo, ossia «superordinato», rispetto a rosa, viola, garofano)>>.
Infatti, non a caso, se scegliamo un’altra unità lessicale, lavoro / lavorare, ci rendiamo conto che le condizioni d’uso non cambiano:
DI MAIO: (…) Lavorare prima possibile per assicurare una maggioranza al governo (…)
SALVINI: Ricordando i principali temi su cui abbiamo voglia di cominciare a lavorare (…)
Martina, chiaramente, su questo non si esprime e, in questo modo, intelligentemente, evita un altro grossolano errore. Se ci soffermiamo un attimo sulle due frasi, ignorandone l’autore, notiamo senza fatica che è assai difficile tracciare un profilo d’identità e paternità linguistica. È evidente che questa non è la sede per offrire al lettore un contributo esaustivo sull’argomento, che richiederebbe approfondimenti importanti, ma, limitandoci a questi spunti, la materia non ci manca affatto.
Luigi Di Maio è indubbiamente il più generoso dei tre. Esordisce al Quirinale con una congiunzione conclusiva, <<Allora, salve a tutti!>>; non pretendiamo che sappia che ‘salve’ significa sta benee proviene dal latino, ma scopriamo che si abbandona entusiasticamente a una specie di anafora postdantesca e sicuramente pentastellata:
Sono stati bocciati i governissimi, i governi tecnici, i governi di scopo (…)
Dato che ‘governissimo’ e ‘governo di scopo’ hanno, grosso modo, lo stesso significato, per quale motivo Di Maio si è esibito in questa inelegante ridondanza? Siccome non intendiamo essere malevoli, lasciamo al lettore il potere dell’interpretazione.
In materia di ridondanza, volgiamo lo sguardo a Maurizio Martina… anche perché Salvini e Di Maio occupano già troppo spazio. Il segretario del PD, a proposito dell’elezione dei Presidenti di Camera e Senato, mestamente dichiara: “(…) Sono scelte che non hanno previsto un nostro coinvolgimento, sono scelte che non sono state fatte di certo casualmente”.
Questo atto si chiama harakiri, non c’è altro modo per definirlo. Perché Martina sente il bisogno di infierire su di sé e sui propri elettori? È naturale che certe scelte siano state fatte senza il partito perdente. Insomma, dopo la finale di champions, non va la squadra perdente a sollevare la coppa. Eppure, Martina, anziché dare contenuto e ritmo al discorso, preferisce il suicidio spettacolare e si avvale, per giunta, dell’uso della negazione per essere incisivo.
Adesso, provando a immaginare, anche solo per un istante e per caso, che l’elettore media sia in una posizione d’inferiorità geo-economica rispetto ai ‘propri’ rappresentanti politici o, per lo meno, a una tale distanza dal pulpito del Quirinale da aver bisogno – legittimamente e almeno una volta – di qualcosa di concreto e tangibile, in modo possiamo definire questo rapporto già fin troppo sbilanciato? Affidiamo la risposta a una brillante intuizione di Watzalawick. La moglie chiede al marito: <>. Il marito risponde: <<sì, amore=”” mio.=”” buonissima!=””>>. E lei, ormai su tutte le furie oppure profondamente delusa: <<com’è possibile?=”” era=”” bruciata=”” e=”” secca.=”” tu=”” dici=”” sempre=”” che=”” tutto=”” è=”” buono!=””>>. Lo scambio che abbiamo appena letto prende il nome di </com’è></sì,>disconferma (ZLAWICK, P., HELMICK BEAVIN, J., JACKSON, DON D., 1967, Pragmatics of human communication A study of interactional patterns, pathologies and paradoxes, trad. it. di M. Ferretti, 1971, Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini Editore, Roma, p. 76), termine con cui Watzlawick et al., per l’appunto, indicano il deterioramento della comunicazione all’interno di una relazione complementare, in cui uno dei due partner, in posizione di superiorità, mostra all’altro una certa indifferenza, spingendo sempre più l’altro verso l’alienazione.
NB: Questo articolo è stato scritto da Francesco Mercadante. Sua nota biografica:
Francesco Mercadante nasce a Erice, il 17 marzo 1977, cresce a Trapani, dove frequenta il Liceo Scientifico Vincenzo Fardella, e completa il proprio percorso didattico laureandosi con lode in Filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo. In seguito alla pubblicazione di alcuni saggi scientifici, fa qualche esperienza di collaborazione e direzione editoriale in Italia e all’estero: in particolare, a Parigi e a Malmö. A ventisette anni, ottiene il primo contratto di docenza all’Istituto di Lettere e Filosofia dell’Ateneo palermitano per l’insegnamento dell’Analisi dei Testi, disciplina che, negli anni successivi, insegna anche in Scienze e Tecniche della Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Nel 2005, il Garante dei detenuti della regione Sicilia gli conferisce l’incarico d’indagare a proposito del Linguaggio dei Detenuti extracomunitari all’interno delle carceri siciliane. Nel frattempo, concepisce e sviluppa un sistema di analisi ‘linguistica previsionale’, ovverosia un metodo di proiezione scientifica grazie al quale diventa possibile prevedere i flussi informativi in materia di finanza, economia, geopolitica e comportamento sociale. La pubblicazione dei suoi lavori lo porta a instaurare proficui rapporti professionali con alcune importanti figure del mondo imprenditoriale. Di conseguenza, lascia l’insegnamento universitario e comincia a viaggiare per occuparsi di internazionalizzazione e dialogo interculturale: Algeria, Tunisia, Marocco, Mauritania, Turchia, Russia, Svezia, Francia, Danimarca, Svizzera e Romania sono solamente alcuni dei paesi entro i quali si sviluppa la sua attività. Si specializza sempre più chiaramente nell’Analisi del Linguaggio applicata alla Finanza e alla Geopolitica e al trattamento dell’informazione, svolgendo assiduamente attività di formatore. Nel 2016, avvia un rapporto di lavoro con l’Agenzia Rotas Consulting di Roma, con riferimento alla Competitive and Financial Intelligence. Si occupa di analisi delle intercettazioni nella procedura penale. Ha scritto e pubblicato sei saggi, due romanzi, quattro opere teatrali e una raccolta di versi. La sua ultima pubblicazione è In principio era il debito il linguaggio dell’economia e della finanza: messaggio, paradosso, spiegazione.
Ps. L’articolo è stato pubblicato in forma originale su questo blog il 22 aprile 2018.